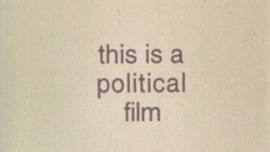"If I think about the future of cinema as art, I shiver" (Y. Ozu, 1959)
Federico Fellini. L’apparizione e l’ombra (Bruno Roberti)
Saturday, 27 March 2021 15:00Lorenzo Esposito
Ho sempre pensato che ci fosse nell’opera di Federico Fellini un processo analitico segreto e sfuggente, una voce lunare che la modulava dall’interno avvitandola e insieme sottraendola allo spettacolo incosciente e profetico di continue e contrastanti fasi luminose e oscure.
Non era solo l’ovvia spinta a liberarsi dalle catene dell’incomprensione (la vulgata, l’equivoco inarrestabilmente planetario - vissuto da Fellini come una vera metamorfosi kafkiana - del fellinismo), ma proprio il ripetersi di un motivo interiore doloroso e di devastante impatto mentale e fisico. Sono anche convinto che è questo a fare di Fellini il secondo polo, da cui tutto discende, del pianeta cinema (italiano e non solo). I due poli in questione si incrociano all’origine di entrambe le carriere (l’uno già un po’ più avanti dell’altro, ma naturalmente predisposto a funzionare come nucleo che ne genera un secondo altrettanto potente) per poi costituire un asse di rotazione bifronte che permette a tutti gli astri successivi di organizzare liberamente il proprio movimento unico e singolare: Roberto Rossellini e Federico Fellini.
Ho sempre pensato che se c’era qualcuno in Italia in grado di arrampicarsi lassù e muoversi con balzi elastici e saggi in questo mirabolante traffico lunare: che avesse nell’uso suo tipico di una parola densa di significati fino all’imponderabile, il tocco magico, angelico quasi, necessario ad avvicinare un pensiero per immagini, quello di Fellini, insieme veggente e fragile, esplosivo e con la neanche tanto occulta ambizione di restare nell’ombra: ebbene, che questa persona fosse Bruno Roberti (senza dimenticare, certo, decenni di interventi e apporti essenziali, che infatti Roberti riporta, anzi direi proprio fruga minuziosamente come nel fondo del mare estraendone perle preziose e rare, nel geniale apparato di note che compendia ed esalta il suo bellissimo Federico Fellini. L’apparizione e l’ombra).
Scrive Roberti nella prima, illuminante, pagina: “L’orizzontalità e la frammentarietà delle immagini felliniane sganciano quindi il suo cinema dall’esperienza autobiografica, perché paradossalmente quelle stesse immagini possiedono come una risonanza universale e impersonale”. Lezione questa, per Fellini, che arriva direttamente da Rossellini, colui che di fatto lo convince a ‘restare’ cineasta (cioè umano) e sul quale anni dopo scriverà a sua volta un paragrafo inarrivato e non per caso troppo poco studiato da tutti i rosselliniani. Coerentemente, Roberti lo riporta per intero poche pagine dopo (e così chi scrive, per puro stupore e ammirazione):
“Rossellini […] viveva la vita di un film come un’avventura meravigliosa da vivere e raccontare allo stesso tempo. Il suo abbandono di fronte alla realtà, sempre attento, limpido, fervido, questo modo di situarsi in modo naturale in un punto impalpabile e unico nel suo genere tra l’indifferenza del distacco e l’adesione impulsiva, gli permetteva di catturare, di fissare il reale in ogni suo spazio, di guardare le cose dall’interno e dall’esterno insieme, di fotografare l’atmosfera intorno alle cose, di rivelare ciò che la vita ha di insondabile, di segreto, di magico. Non sarà forse tutto ciò il neorealismo?”1
Ora, al di là del fatto che è difficile trovare una ricostruzione del metodo rosselliniano altrettanto precisa e ispirata (compresa l’ancor più decisiva frase finale sul neorealismo che, col tipico tratto felliniano che unisce umiltà e ironia, si mantiene interrogativa), vi è inoltre racchiusa l’auto-analisi più lucida di ciò che di quel metodo si è tramutato nell’altro polo, con simile forza creatrice, ma espandendosi nell’impervio territorio creativo del paradosso e dell’inconscio.
I film di Fellini nascono da uno stato di crisi, o meglio possono essere fatti solo sul punto di fuoriuscita dalla crisi (che spesso non ha fine e si perpetua sul set). La crisi più nera, tremenda, che unisce depressioni abissali a odio assoluto per il film da fare. Si potrebbero suddividere i film di Fellini tra quelli che si lasciano andare a una quiete dopo la tempesta e quelli che invece ne traggono vantaggio perfino aizzandola e, come se fosse il film stesso a dirigere il regista, la sfruttano per valorizzare poeticamente il dato funereo.
Sfatiamo infatti un luogo comune. In Fellini amore per i propri personaggi, per i propri ricordi, per i propri sogni o visioni: questo mai, o pochissimo, e sempre, alla fine (di ogni film), un senso di vuoto e angoscia indelebili. Si rilegga il carteggio sublime Fellini-Simenon che, curiosamente, manca tra i certosini riferimenti di Roberti (lo segnalo benevolmente, da fratello - così come Simenon nell’abbrivio di una lettera dice ‘Caro Fellini, fratello’ e in un’altra ‘Caro grande Fellini’, dirò caro Roberti, fratello e caro grande Roberti - soprattutto affascinato dal processo inconscio che può aver portato all’assenza di questo testo essenziale). Fellini esce da quella che chiama la “condanna” di dover fare Il Casanova (probabilmente, secondo Simenon, il suo capolavoro) dopo un sogno liberatore in cui Simenon stesso gli appare indicandogli la strada; e Simenon (come Fellini con Rossellini) risponde alla rivelazione scrivendo sul cinema di Fellini le parole definitive (che riporto, di nuovo, con stupore e ammirazione)2:
“Probabilmente lei è l’unica persona al mondo cui mi senta legato sul piano creativo. […] Tutti e due siamo rimasti, e spero che tali resteremo sino alla fine, dei ragazzi cresciuti che obbediscono a impulsi interiori e spesso inesplicabili anziché a regole ormai prive di significato sia per lei che per me”[…]
“Come me, lei è un istintivo, credo di averglielo già detto, e quel che ha involontariamente registrato sin dall’infanzia, quel che ancora oggi continua inconsciamente a registrare, lo restituisce con forza centuplicata che delle sue opere opere universali.
La stessa cosa, anche se in piccolo, succede a me. Ed è sempre successa a Jean Renoir.
Siamo come spugne, assorbiamo la vita senza saperlo e la restituiamo poi trasformata ignari del processo alchemico che si è svolto dentro di noi”
“[…] lei crea con il suo inconscio e quando, come ora, si sente vuoto, è invece il momento in cui dentro di lei si compie il lavoro vero e proprio”
[…]
“Lei è un poeta maledetto, come Villon e Baudelaire, come Van Gogh e Poe. Io chiamo poeti maledetti tutti gli artisti che lavorano molto di più con l’inconscio che con l’intelligenza, che anche volendo non potrebbero fare se non quello che fanno e che a volte creano mostri, ma dei mostri universali”
Entrambi innamorati del circo: la lettera in cui Simenon rivela a Fellini gli anni in cui faceva il cronista con una rubrica sul circo a Liegi nel 1916 e poi la sua amicizia con la famiglia di clown Fratellini, che appaiono guarda caso ne I clowns di Fellini, e la storia d’amore con l’ultima della stirpe, se non fosse di per sé impagabile, sarebbe addirittura inquietante per corsi e ricorsi astrali.
Entrambi, soprattutto, cultori di Jung, e in particolare di quella che Fellini definisce “misteriosa sincronicità”: accadimenti esterni che coincidono, estranei e apparentemente senza una logica pre-ordinata, con altrettanti accadimenti interiori, per cui, con meno quotidiana distrazione, potremmo comprendere meglio i rapporti tra pensiero e materia. Fellini si riferisce semplicemente al fatto che tutte le volte che si trova immerso nell’angoscia più profonda giunge l’accadimento esterno - una lettera di Simenon: ma tutto questo processo in cui la materia esterna, attraverso una coincidenza inconscia, genera pensiero, è il processo (come Simenon evidenzia) dell’opera felliniana.
Per questo Roberti, nel tuffarsi a sua volta in questo mare in tempesta, in questi naufragi cosmici, insiste molto sul potere che in Fellini ha il fare film stesso, e non il racconto. Sono le immagini che lo attraversano, non il contrario, e, in quanto attraversato, non può che stupirsene. In questo, peraltro, in contatto perpetuo col polo-Rossellini, anzi, rosselliniano fino al midollo. Roberti non perde mai di vista questo crogiòlo comune che si irradia e si divarica lungo la dorsale variegata del cinema italiano: “Ma se il risvolto simbolico si dissimula nel film, persiste l’idea di erranza neorealistica e il labirinto animico si concreta nella strada come forma della vita e del destino collettivo, da cui scaturisce la violenza e la potenza dell’essere gettati nel mondo (è la lezione di Paisà e di Francesco giullare di Dio, assimilata da Fellini accanto a Rossellini)”. Roberti sta in questo caso parlando de La strada, ma appare chiaro che questa mirabile ricostruzione ideale è in realtà la nervatura stessa dei film di Fellini: indifferenza per il simbolo, erranza pura e rossellinianamente aggrappata alla realtà storica o contemporanea come luogo insieme vero e ineffabile e al limite del meraviglioso, inconscio che risale la corrente e si interroga sulla vita di tutti riconoscendo “un dolore che ciascuno porta in sé”3 (si pensi, cito a caso, a Il bidone, a Fellini Satyricon, a E la nave va).
Roberti cuce nel suo libro un fil rouge che riconduce tutto il lavoro felliniano alla posizione (all’inconscio) dello spettatore. Si ricordi, non a caso, il metodo di Fellini di non guardare mai i giornalieri, ma solo alla fine, come un vero spettatore, di farsi proiettare tutto il materiale e da lì cominciare a lavorarlo come un unico grande subconscio che vive e respira. Fellini è il primo stupefatto spettatore di se stesso, e per questo la situazione e il processo stesso del guardare sono al centro dei suoi film. È un caso talmente unico nella storia del cinema, che per scriverne è necessario verificare continuamente la distanza giusta e al tempo stesso immergersi senza timore nelle sue magnifiche contraddizioni.
È dunque per stare al passo di Fellini che Roberti, dopo aver allontanato la matrice autobiografica, con doppiezza felliniana la riporta in gioco e piomba senza paura in una dimensione creatrice più avanzata: “È significativo come dall’incrocio tra set e avvenimenti reali nascano, quasi per proliferazione, degli intrecci tra immaginazione e vita, a conferma del fatto che il tracciato biografico per Federico è interconnesso con il “vivere” il film”. Il set è pronto per diventare il tutto nel tutto che lo circonda. La narrazione è pronta per sperimentare il gioco ininterrotto di apparizioni e trasfigurazioni. L’immagine è pronta per essere la membrana “ipersensibile” che letteralmente respira il film e chi lo guarda. I cosiddetti “finti documentari-inchiesta” (che sinceramente fanno impallidire tutto l’odierno chiacchiericcio intorno all’illusoria linea di demarcazione tra fiction e non fiction) sono l’unica via possibile di un documentario che davvero desideri avere a che fare con la realtà: operazioni sciamaniche, viaggi medianici.
Grazie a queste intuizioni il libro di Bruno Roberti raggiunge uno stato di grazia in cui la parola e l’immagine si scambiano visioni terminali. Fellini difficilmente verrà più parlato con la medesima lingua misteriosa e rivelatrice che i suoi film sperimentavano sul campo. Cos’erano questi film? “Una sola grande immagine-brulichio entro cui lo spettatore, insieme al regista, può vagare come in un labirinto”. Cos’era Il Casanova? “Un balletto d’ombre elettrificato”. Cos’è il racconto? Una visione aerea, ventosissima, in cui “la finzione getta le sue ombre perché diventa via via la stoffa in cui si materializza, come un ectoplasma, quel mondo onirico che può rivelarsi anche minaccioso”. Dove finiscono tutte queste rovine circolari al termine della “danza macabra” (Roberti cita Eliot e Deleuze, ma vengono in mente anche Ophüls, Beckett..)? “Salvarsi e perdersi in un sol momento, tale è il destino delle immagini felliniane, della loro germinazione, che nasce da una fermentazione, da un deterioramento”. Cos’è la cinepresa? L’ultima delle apparizioni, un’ombra, un impaccio (di nuovo Rossellini): “Me ne frego dell’obiettivo. Devo essere in mezzo alle cose. Ho bisogno di conoscere tutto e tutti, di fare l’amore con tutto ciò che è intorno a me” (Roberti scova questa decisiva dichiarazione di Fellini che arriva a noi dal 1971). Cos’è la realtà? “Non si tratta tanto di fantasmi, di spiriti, di insorgenze dell’altra dimensione, quanto della possiilità di ‘vedere’ un rovescio del reale. Di rovesciare puntualmente la mise en scène”. Cos’è il tempo? Cos’è lo spazio? “[…] un corteo, una parata di creaure sommerse che sbucano dagli angoli più impensati delle inquadrature, piuttosto che in una ricostruzione del passato, in una sua decostruzione proiettata nella sconosciutezza dell’avvenire”. Roberti qui sta infine volando con Fellini, suo fratello:
“Si aprono abissi, palpitano nel momento in cui precipitano le visioni, un ribollire sotterraneo che continuamente emerge come dal fondo materico della pellicola. Le immagini fermentano alchemicamente. L’orizzonte è basso e incombente eppure si apre in squarci infiniti. Una ‘adimensionalità’ in cui le forze imprimono in modo incessante alle forme una deriva. Un naufragio di detriti scomposto in posture indecifrabili, impastato di gesti sospesi, di cifre corporali inorganiche in cui le ombre ancora una volta danzano ma in un balletto arcano e automatico”
Nessuno come Fellini ha esplorato (a sue spese, sempre sull’orlo del crollo nervoso) questo aspetto dell’immagine e di quello che il cinema scommette di continuo nella sua conversazione con e attraverso l’immagine: essere al tempo stesso uno sguardo sulla morte e il rinvenimento di un luogo di rinascita. Senza mai tuttavia - questo è d’altra parte più difficile e di pochissimi (Rossellini di sicuro, poi Ferreri, Sergio Citti e pochi, davvero pochi altri) - prendersi sul serio, se possibile combattere se stessi fino a ‘bidonarsi’ (il capolavoro Il bidone, non solo è l’entrata definitiva di Fellini nel mondo dei fantasmi che disarciona in un sol colpo il proprio cinema e lo spettatore, ma è l’ordigno che - talmente potente da risultare ancora oggi quasi invisibile - compendia e rovescia la storia del cinema italiano fino a quel momento). Solo così può cominciare il traffico sacro di segni che porta a giocare pericolosamente con l’oscurità e a farsi follemente attraversare dallo spreco e dalla tentazione di non finire mai e di ricominciare sempre (Il viaggio di Mastorna).
1 F. Fellini, Fare un film, Einaudi, Torino 1980, p.138.
2 Carissimo Simenon Mon cher Fellini, Adelphi 1998. Le cit. che seguono sono ripettivamente alle pp. 36-37, 41, 69, 132.
Lorenzo Esposito
Sunday, 07 June 2020 21:06Antofagasta
(appunti per un romanzo-diario su Walter Benjamin)
L’andatura di WB: in una pagina del diario giovanile di Pentecoste racconta di come si fosse smarrito a Venezia per colpa di un’esitazione. Tornando con lo sguardo dove li aveva lasciati gli amici non c’erano più. Vaga per la città tutto il giorno e li ritrova allo stesso modo in cui li aveva smarriti, gli si fanno davanti come una visione. Il modo in cui si perde a Venezia è un passo in caduta libera ma caparbio nel restare incollato alla visione, ha già l’andatura dei verbali delle esperienze con l’hascisch (e del racconto Hascisch a Marsiglia). Nel racconto “Il viaggio della Mascotte” l’omonima nave parte da Antofagasta diretta verso il capo opposto del mondo e, dopo uno smarrimento autorivoluzionario (e insieme indotto) dell’equipaggio, approda di nuovo nel porto di Antofagasta (Raúl Ruiz potrebbe facilmente chiosare - v. La noche de enfrente). Nel Diario moscovita, uno o due giorni prima di lasciare la città, l’episodio della passeggiata mancata con la Reichlin. La corsa di lato al tram dove lei è salita al volo, l’indecisione se salire, qualcosa che glielo impedisce, la camminata nel gelo fino alla fermata successiva (nella Piazza Rossa), dove però la Reichlin non c’è (si saprà poi che era scesa ma lo aveva cercato nelle strade intorno alla Piazza). Allora la decisione di salire su un altro tram, forse la verità di un desiderio nascosto, e andare senza meta fino al capolinea, vedere una Mosca mai vista e tornare indietro. In una lettera a Gretel Adorno da Ibiza racconta la sua mattina: sveglia alle sette, bagno, immagine dell’orizzonte sul pelo dell’acqua, nessuno in giro, bagno di sole appoggiato a un albero. La Arendt cita Rychner sull’andatura di WB: “un avanzare e un indugiare al tempo stesso, una strana mescolanza delle due cose”.
Scrivere inappariscente: è come sotto hascisch, la linea che vibra senza vibrare tra un’immagine e l’altra, ma senza necessità di assumerlo. I pochi che conoscono il segreto li cita apertamente (e ne scrive a lungo): Franz Kafka, Robert Walser, J. P. Hebel. Le parole scivolano da se stesse e lasciano per strada delle lettere pur restando intatte. L’effetto che si prova nella lettura è di matematico smarrimento a un determinato punto (ognuno il suo, l’effetto è diffuso e resta inalterato lungo tutto il testo), ci si ferma e si torna indietro con l’impressione di aver perso il filo e nel rileggere si ritrova tutto come prima anche se tutto mutato (e viceversa). Anche questo è da legare al concetto di storia. Ogni lettore è il suo Angelo.
Scrivere una volta per tutte: nel Diario moscovita riporta una conversazione notturna con Bernhard Reich in cui quest’ultimo - cosa che WB giudica “pertinente” - gli dice che il tempo di elaborazione della sua scrittura è troppo lungo e che se nei grandi scrittori (intende: persino in loro) si trova una frase “particolarmente convincente e pregnante” ogni trenta, in WB una ogni due. E con questo lo fissa non solo come scrittore irripetibile ma, in una parola, folle (forse da inserire in quella collezione di testi di malati di mente che costituiva, insieme a quella sui libri per bambini, l’orgoglio della biblioteca di WB). Scrivere sempre la frase definitiva. Molto spesso, forse non è un caso, questa prova estrema cui viene sottoposta la frase coincide con un salto logico a dir poco rocambolesco, e che per di più lo è, come detto sopra, in modo da risultare inappariscente.
THE LAST THINGS BEFORE THE LAST (3) - LA FRANCE contre les ROBOTS (Jean-Marie Straub)
Sunday, 07 June 2020 12:41Lorenzo Esposito
THE LAST THINGS BEFORE THE LAST (1) - Siberia (Interview with Abel Ferrara)
Sunday, 07 June 2020 12:40
Lorenzo Esposito, Giona A. Nazzaro
BIBI ANDERSSON
Wednesday, 05 February 2020 22:42Lorenzo Esposito
Beröringen (titolo inglese The Touch, titolo italiano L’adultera, anno 1971) è il film più segreto e incompiuto e tanto cruciale quanto volutamente sotto tono di Ingmar Bergman. Una ballata triste e romantica d’autunno. Un autunno infinito, senza sinfonia, senza più stagioni prima o dopo, solo un manto di foglie livide e infuocate insieme che scendono lente a terra. Fra di loro ce n’è una più resistente delle altre, più pura, l’unica che crede alla sua stagione, che non ha paura di credere in qualcosa, che sa cosa è un inizio e cosa una fine. Ha il volto serio e dolce la foglia Bibi Andersson, l’attrice forse più vicina a calibrare l’incalibrabile squilibrio tra il lavoro mimetico e di denudamento dell’attore. Posso vedere una foto di sua moglie nuda, dice Elliot Gould a Max Von Sydow. Ma non c’è bisogno di chiedere. Guarda. Guardati. Lei ci prova a spiegartelo, con tutte le sue forze, ma tu non ti sposti di un millimetro. Voi non vi spostate di un millimetro. Voi che accusate lei di non saper prendere decisioni, lei che le ha prese tutte per prima e subito con quel suo talento assoluto e insuperato di depotenziare anche questa forza evidente, quest’occhio che vede dove agli altri non è permesso, ma senza voler dimostrare nulla, cancellando ogni passo, attaccata spasmodicamente alla purezza che le è propria per istinto, e quasi senza darsene a vedere. Un vera musa. Più di altre con cui Bergman ha lavorato a fondo. Quella che incarnava qualcosa che forse neppure lui, se non raramente, ha raggiunto, ma che intuiva fosse lì, dentro quegli occhi e quel volto che, col minimo movimento, lavorato allo stremo e insieme completamente inavvertito, ne rilancivano decine, centinaia.
Tully (Jason Reitman)
Sunday, 28 April 2019 21:11Su una certa lacuna di alcuni film
Lorenzo Esposito
Il titolo stesso di questo speciale non arriva alla precisione con cui un film come Tully misura esemplarmente il livello di fragilità (che ritorna metaforicamente nell’idea di eterno non-passaggio all’età adulta - Young Adult recita spudorato un Reitman 2011) di un piccolo selvaggio mucchio di film un po’ troppo e non a caso segretamente amati nel corso dell’anno appena trascorso. Minding the gap appunto, prendersi cura delle loro mancanze e forse del loro volersi mancare, è un modo per restituire quel che tuttavia, di questi amici fragili, attiene al puro desiderio. Filmicamente, questo è il punto, è proprio questo non-passare a doversi intendere piuttosto come passaggio verso un differente confine, un po’ più labile, invisibile, un po’ meno facilmente declinabile, che ne segnala, volutamente sottotraccia, l’interesse e la bellezza possibili. Tully svolge quasi serenamente tale riflessione su una certa lacuna di alcuni film (e non più mai su una certa tendenza), su un certo modo di sparire e poi di riaffiorare come ipotesi di inattualità che costituisca il nucleo stesso del filmare (tutto Reitman, d’altra parte, si muove felpato su questo crinale). La questione dunque non è se Tully sia un film bello oppure no. Intanto lo è, così come e in quanto meravigliosamente desueto, seccamente anti-catartico, film illusionista che non offre illusioni, ma analizza invece una materia convulsa e politica che riguarda la donna e il suo corpo senza mai scadere nei patetismi sociologici e ideologici che appiattiscono e esacerbano e tradiscono. Si tratta di interrogarsi cosa lo distingua, all’interno di quella che una volta, e che invero non si è mai interrotta, si poteva definire produzione media americana (non è più il caso di usare la parola hollywoodiana). Cosa ne faccia un film unico e che si muove su livelli di intensità che, per esempio, nessun annacquatissimo medio film Netflix sembra in grado di raggiungere (nessuna polemica, solo constatazione, visto che d’altronde il gigante tentacolare on-line forse proprio non vi è interessato, ormai i casi di film appena accettabili o guardabili con la distrazione meccanica con cui la mattina ci laviamo i denti pensando ad altro non si contano più). Uno dei motivi è sicuramente Charlize Theron, o meglio la complicità con cui la leggerezza di Reitman e la caparbietà dell’attrice, lavorano il corpo trasformandone la mutazione da processo narrativo a vero e proprio tessuto filmico. Il fatto che questo ‘passaggio’ avvenga quasi silenziosamente, giocando all’apparente linearità di intenti e intreccio, è ciò che distingue Tully dalla gran massa di film che si beano a ricalcare orme altrui, soddisfatti di essere riconoscibili e niente più (sia chiaro, inferiori anche alla scrittura che pretende di essere regia di talune entusiasmanti serie). No, qui la cosa che si vede è il lavoro dell’attrice, il quale tuttavia è il vero e forse geniale mcguffin in grado di mascherare il lavorìo del film, di farlo scorrere su un piano più segreto che invita a guardare oltre i fatti, a scrutare fra le maglie, in modo che molte cose non tornino e che anche la sorpresa finale risulti depotenziata al punto da produrre il desiderio immediato di rivisione alla luce dell’elemento tanto apparentemente invisibile. Ecco, Reitman, a differenza di altri, non è mai stato uno shooter, ma un regista che fa della mutazione e della crisi d’identità una possibilità di investigazione dell’invisibile che ci riguarda e che dunque riflette sulla necessità di imparare a convivere con questa malinconia. Ci si illude di vedere o di vedere tutto, fino alla fine delle illusioni.
Jean-Luc Godard
Thursday, 06 December 2018 00:13Le livre d’image
Lorenzo Esposito
Non è la prima volta che Jean-Luc Godard per parlare d’immagine parla prima di tutto di ciò che attiene al tatto. Non proprio di un ‘occhio tattile’ tuttavia, nel lavoro di JLG ci possono essere grafi, grafie, tavolozze Fauves rinvenute direttamente nel ventre dell’immagine - ma mai metafore. No, semplicemente Godard parla delle mani. Lang Rossellini Hitchcock. In rapida successione. Mani. Non solo per voltare le pagine del livre o per ‘scrivere’ l’image o per scorrere la pellicola (anche leccarla come Jerry Lewis, parte della storia fisiologica del tatto è nella lingua, nella saliva). Mani come condizione primaria dell’umano. “La vraiè conditíon de l’homme: penser avec ses mains”.
Invero, nulla di meno pacifico. Le dita sono cinque e la composizione origina risultati non preventivabili. Da un lato l’archivio e il suo sistema morale, dall’altro la dannazione di chi decide di intraprendere il viaggio tra immagine e parola senza dire stronzate (“pour ne pas faire caca”/”no bullshit”). Un incubo in una notte di tempesta – i fatti, gli eventi reali, visti come esperienza non di ciò che si fa, ma di quello che non si fa (JLG lo ripete come un mantra durante la scorribanda via face-time che ha scosso dal suo torpore il festival di Cannes e che in mancanza di meglio chiamiamo ancora conferenza stampa). Nulla a che vedere con la parola tanto in voga fake, al contrario un tentativo estremo di maneggiare la bellezza attraverso l’apparentemente dimenticato romanticismo della menzogna come passage per la verità (Benjamin, n’est-ce pas?).
La sequenza di Johnny Guitar, con la sua semplicità e ambiguità al cubo, giunge come un lampo: l’amante dice all’amata dimmi delle bugie, cioè delle verità in forma di menzogne, ripetimi le tue frasi d’amore con l’odio di chi sa di mentire perché dice la verità. “La guerre est lá”. (È da poco scomparso Philip Roth che amava ripetere una cosa come capire la gente non è vivere, vivere è capirla male). Godard, che molto tempo fa aveva rifatto la scena in Le Petit soldat, teneramente ce la mostra. È il primo capitolo di Le livre d’image: Remakes. Che, appunto, diventano rim(ak)es. Ma il poeta è il primo a sapere l’abisso di inconciliabilità contenuto in ogni rima, un secondo un’ora un giorno corrispondono a un giorno una vita l’eternità. Seguono tortura, punizione, l’innocente che paga per colpe non sue. Questo succede a chi cerca di decifrare l’imagine, tragicamente mette altra realtà nella realtà. Come se nulla fosse Godard giunge qui subito al punto cruciale (e subito, alla sua maniera, se lo mette alle spalle): “nessuna attività diventa un’arte prima che la sua epoca, il suo tempo non sia finito, e allora scompare”. Per questo si può non smettere di chiedere che cos’è il cinema, che forse non è neppure ancora un’arte, e che ha questa capacità di giocare a scomparire, di saltare a piè pari epoche e tempi inventando continue sparizioni. Ma ciò non toglie l’orrore delle leggi, la fine della democrazia, la fine del sogno di riscatto degli umiliati e degli offesi.. Ciò non toglie questa Europa senza virtù né futuro..
Così la prima parte dell’ultimo Godard, Le livre d’image, che il Festival di Cannes, senza saper bene che fare, onora della palma d’oro special a conferma lampante di genericità e medietà dei festival tutti. La prima parte, ovvero sotto gli occhi dell’Occidente. Il film è da subito e fino alla fine un trattato di stereofonia, che delocalizza lo spazio uditivo attraverso il rincorrersi e incrociarsi e sovrapporsi delle voci delle frequenze dei volumi (mix oltreumano che ha la follia e il desiderio di un’ulteriore salto mortale, visto che JLG e la sua équipe lo hanno pensato appositamente per la sola sala Lumière di Cannes, e ora sono al lavoro per rifarlo daccapo e presentare il film ogni volta come un happening – “in qualche piccola sala di cultura o in qualche circo” dice ironicamente il già citato Godard versione face-time). E che diffonde l’energia pluri-auricolare sull’immagine stessa - estratti da film propri e altrui, brani anonimi cine-tv e Internet, quadri, grafie, illustrazioni, libri, pennellate, sbavature – scegliendone sempre la versione peggiore, sgranata, decomposta, bruciata dal sole, colata a picco, non più supportata dal supporto, smagnetizzata, graffiata, sradicata. Spesso lo stesso frame, la stessa immagine viene modificata in asse, sformata deformata riformattata, 4:3 e 16:9, cinema tv cinema tv cinema… (non c’è lo spazio necessario, ma andrebbe pensata la vicinanza di Le livre d’image a un film come Vent d’est, non solo per la struttura, lo vedremo, bipartita e la trama, proprio la nervatura tragica e politica insieme, ma per quest’opera di continuo auto-sabotaggio del film e dell’immagine e del ruolo stesso del cineasta, con cui Godard sembra voler ritrovare nell’apparente disfunzionalità del corpo del film il corpo vivo, se è ancora da qualche parte vivo, dello spettatore, chiamato non certo a decifrare la folla di segni parmi nous, quanto piuttosto a liberarsi della propria normatività di decifratore o interprete, e invece fare esperienza della continua disfatta dell’immagine per giungere a essere un’immagine. Da cui il famoso “non è un’immagine giusta, è giusto un’immagine”, che più recentemente Godard ha chiosato spiegando che “i miei film si inseriscono in una corrente della sinistra europea che vola di disfatta in disfatta, in un bello slancio romantico”. Romanticismo che appunto diviene ora il perno di Le livre d’image)…
Fino al capitolo 5, non a caso intitolato La Région Centrale, vertigine che apre al secondo lunghissimo blocco tutto dedicato al mondo arabo, o meglio alla “heureuse Arabie”. Ma intanto l’omaggio a Michael Snow - a quella sua sublime e interstellare esplorazione dello spazio capace di lanciare il tempo oltre stesso, di spalancarlo, squarciarlo dall’interno - ricongiunge il film al suo inizio: quando il tempo è fuori sesto, quando manca a se stesso, quando non abbiamo più nulla da aspettarci, “ci sono cinque dita, la mano”. E le mani bisogna sporcarsele e tornare a parlare del mondo arabo, nucleo da sempre decisivo e non certo per la tragedia che intende finire di stringerlo nella morsa (uno dei film più profetici di tutta la storia del cinema è e resta Ici et ailleurs, firmato da Godard con Anne-Marie Miéville a metà degli anni settanta). Il mondo arabo che non è l’Islam, sia detto in principio. Principio gioioso, appunto. Mentre il cristianesimo è il rifiuto di conoscersi, “la morte del linguaggio”. Qui lo sfogliare il libro dell’immagine araba (da Edward Said a Pasolini all’orrore attuale) è per Godard un modo per spogliarla della violenza con cui viene rappresentata, vista solo politicamente o confusa col Medio Oriente, perché in fondo né il mondo né i mussulmani sono interessati agli Arabi. “Les arabes peuvent-ils parler?” Gli arabi possono parlare? Non so in quanti oggi abbiano la stessa lucidità e insieme tenerezza di porsi questa domanda come fa Godard. Di ricordarsi come questa voce araba, fatta di paesaggi e colori d’infinita intensità, ha saputo e sa dire cose giuste, trovare il volume giusto per dirle. Proprio questa è l’immagine che si cerca di cancellare e di evitare che accada, è un modo per prolungare il giogo. Che orrore.
Ora il film, Le livre d’image, è un fiume in piena, una colata di marca strettamente pittorica e musicale, dove Godard sembra voler dire che è solo l’arte del contrappunto a produrre una melodia. Le livre d’image non crede nella musica d’accompagnamento, ma nell’interruzione, nell’eco, nella deflagrazione, nel viaggio coraggioso fra le macerie (l’Aldrich di Kiss Me Deadly appare quasi subito e anche il Tourneur di Berlin Express). Uno dei pochi, Godard, ancora a credere che il conflitto non è fatto solo per distruggere. Anzi è qui che un’armonia possibile va ricercata. È anche, questo passaggio, lo sprofondamento più romanzesco del film. Il sogno. Le mille e una notte. La città di Dofa. Esempio immaginario che riporta l’immagine alla sua realtà politica. “La scusa d’ogni ambizione politica è quella di fingere di sacrificarsi per il bene del popolo quando il popolo non ha chiesto nulla se non di vivere in pace”. Ma soprattutto, come diceva Brecht, “solo il frammento porta il marchio dell’autenticità”. Siamo alla corsa finale, una delle più commoventi mai viste al cinema. Ci vorrebbero libri interi di immagini, ma di nuovo il cinema sembra capace di questo paradosso fatto di fulmineità e durata. Godard parla e la sua voce si spezza, la cede a Anne-Marie Miéville, la riprende rauco, tossisce. In gioco c’è il soggetto stesso, la necessità di una rivoluzione (“il doit y avoir un revolution”). Sapere che quando si parla a se stessi si parla con la voce di qualcun altro che si rivolge a noi stessi. E se questo è il segreto dell’immagine, allora le nostre speranze, le speranze di una vita, resteranno. Resteranno immutabili. Come la sequenza del ballo tragico dionisiaco romantico da Le Plaisir di Max Ophüls che chiude o riapre le livre d’image.
Questo testo è apparso in prima battuta su Alfabeta2 il 27 maggio 2018.
SIGNS OF CHAOS (2) - Zan/Killing (Conversazione con Shinya Tsukamoto)
Sunday, 02 December 2018 18:59Lorenzo Esposito
SIGNS OF CHAOS (3) - Seducão da carne (Conversazione con Julio Bressane)
Sunday, 02 December 2018 18:59Lorenzo Esposito
Ultimi articoli pubblicati
- 2025-03-24 Chime/Cloud/Serpent’s Path (Kurosawa Kiyoshi)
- 2025-03-24 Abiding Nowhere (Tsai Ming-liang)
- 2025-03-24 The Box Man (Gakuryū Ishii)
- 2025-03-24 Grand Tour (Miguel Gomes)